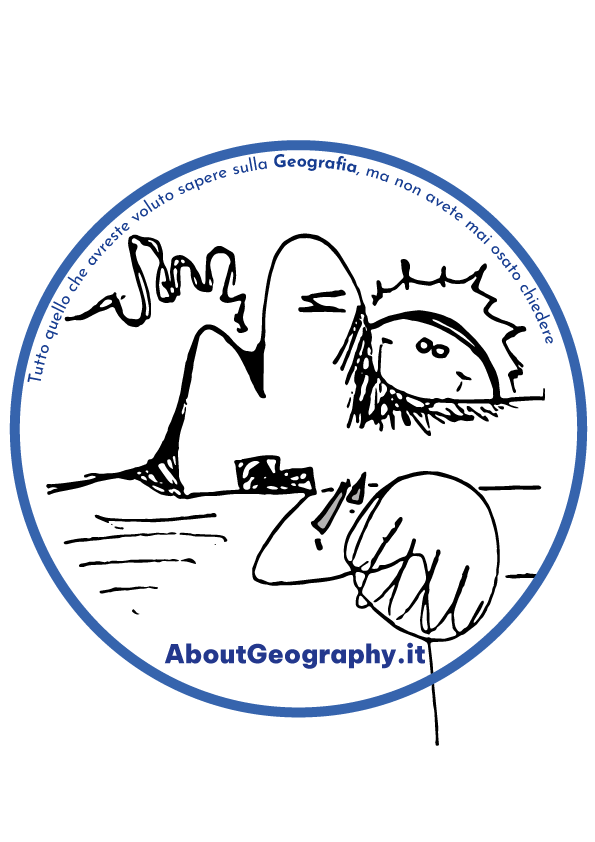Le elezioni regionali 2025 hanno confermato gli equilibri politici già noti: il centrosinistra ha mantenuto il controllo in Campania e Puglia, mentre il Veneto resta saldamente nelle mani del centrodestra. Ma il vero protagonista di questa tornata è stato l’astensionismo, che ha raggiunto livelli mai visti negli ultimi decenni. In tutte e tre le regioni, meno di un elettore su due si è recato alle urne. In Campania ha votato circa il 44% degli aventi diritto, in Puglia appena il 42%, mentre in Veneto l’affluenza si è fermata al 44,6%. Un calo drastico rispetto al 2020, quando la partecipazione superava il 55% al Sud e il 61% al Nord.
Perché non si vota più? Principalmente per disaffezione politica: in Italia, come altrove nel mondo, cresce sia la sfiducia verso la classe politica e verso le istituzioni sia la percezione che il voto non cambi davvero le cose; e forse questa volta hanno giocato un ruolo anche i tre esiti scontati, perché in questo caso si è avuta la netta sensazione che i vincitori fossero già decisi ha spinto molti a restare a casa. E chissà quanto, almeno nei giovani, può aver influito la percezione che non sia più la politica a comandare le regole globali del gioco, ma l’economia e la finanza.
Ecco come è cambiata l’affluenza nelle ultime tre elezioni regionali.
| Regione | 2015/2016 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Campania | ~50-55 % | 55,5 % | 44,1 % |
| Puglia | ~54-60 % | 56,4 % | 41,8 % |
| Veneto | ~59-63 % | 61,1 % | 44,6 % |
Il trend è chiaro: in dieci anni la partecipazione è scesa di oltre 15 punti percentuali, e il voto degli under 35 anni è diminuito del 15% dalle precedenti elezioni. Un dato allarmante. Per quanto riguarda l’analisi geografica della rappresentatività del voto complessivo, il calo non è uniforme: nelle aree urbane, come Napoli e Bari, l’astensionismo è stato ancora più marcato. Questo ridisegna la geografia politica: i partiti vincono, ma su basi elettorali sempre più ristrette. In Veneto il centrodestra resta forte, mentre al Sud il centrosinistra tiene, ma con un consenso reale molto ridotto.
È doveroso ricordarlo: quando più della metà degli elettori non partecipa, la rappresentatività delle istituzioni si indebolisce e si lascia il via libera a populismi e aspirazioni dittatoriali. Il “primo partito” diventa chi non vota (e a decidere sono gli altri). È un segnale che non possiamo ignorare, oggi più che mai: la sfida non è solo politica, ma culturale e sociale. C’è in ballo l’essenza stessa della democrazia, in Italia come nel resto del mondo.